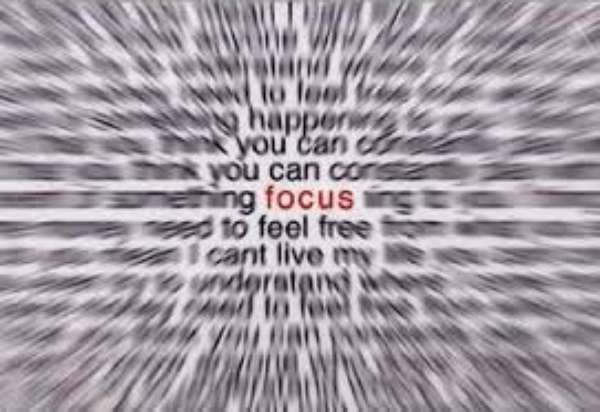In perenne crisi d’identità, in mezzo al guado di una transizione riformista ancora incompiuta, i Democratici di Sinistra rischiano di farsi adescare dalle sirene del massimalismo, sempre dotate di nuovi spartiti. Secondo queste ultime, l’insuccesso nelle elezioni europee dello scorso giugno è dipeso dall’annunciata svolta riformatrice in materia previdenziale e dai propositi di modernizzazione mostrati dal capo del governo. Il corollario di questa interpretazione è semplice: i Ds devono marcare con maggiore incisività il loro “essere di Sinistra”, ed evitare di mettere a repentaglio il legame con la loro base sociale ed elettorale (in termini pratici, con i sindacati confederali). Il messaggio è passato senza colpo ferire. Nessuno- complice la calura estiva- ha sentito il bisogno di aprire un dibattito su quale debba essere l’identità di una sinistra di governo nell’Italia e nell’Europa di oggi. Nessuno ha ritenuto utile interrogarsi sui benefici e i limiti della concertazione, elevata dalla sinistra a surrogato del processo decisionale democratico, in seguito alla crisi dei partiti tradizionali. Eppure, a nessuno dovrebbe sfuggire che soltanto da un dibattito approfondito su questi due temi potrà nascere e mettere radici nel paese una sinistra autenticamente riformista.
Proviamo a riflettere sul secondo punto: il ruolo della concertazione, cioè della prassi più o meno istituzionalizzata di concordare le principali misure di politica economica e sociale con gli interessi organizzati. Per i suoi sostenitori, come il ministro del lavoro Cesare Salvi, la concertazione è l’unica via per produrre riforme e sviluppo senza sacrificare la coesione sociale. Per i suoi oppositori, come l’economista Alberto Alesina, la concertazione impedisce l’adozione di provvedimenti impopolari ma necessari per animare la crescita economica, come la riduzione della spesa pubblica e- in sequenza- del cuneo fiscale sul lavoro. L’aspetto fondamentale, tuttavia, non riguarda i “pro” e i “contro” in generale, ma il “rispetto a cosa” e il “dove”: rispetto a quali materie o in quale contesto politico-istituzionale il metodo concertativo si rivela più efficace di altri processi decisionali, e rispetto a cosa o dove avviene il contrario?
Un primo tentativo di incanalare il dibattito in questa direzione è stato fatto- in un commento sul Sole24Ore- da Carlo Andrea Bollino, che ha richiamato alcuni risultati della teoria delle scelte pubbliche, un recente filone di ricerca che utilizza gli strumenti della teoria economica per studiare gli esiti dei processi politici. Bollino sostiene che il metodo della concertazione (da lui assimilato a una votazione in comitato con manipolazione dell’agenda) e quello della valutazione pura (da lui assimilato all’analisi costibenefici) dovrebbero essere usati in ambiti diversi: il primo per scelte a contenuto etico (come la lotta all’inflazione) e il secondo per scelte a sfondo economico (come il rilancio degli investimenti). Questa analisi, sebbene abbia il merito di chiarire che la performance dei metodi decisionali dipende dai campi di applicazione, lascia in ombra molti aspetti. Anche l’interazione strategica tra i diversi attori meriterebbe di essere esaminata. Ed altri contributi della teoria delle scelte pubbliche dovrebbero essere richiamati,
in particolare quelli che studiano l’influenza dei gruppi d’interesse sulle politiche pubbliche delle democrazie rappresentative.
Un problema di duplice free-riding
Il quadro teorico di riferimento per un’analisi del genere è rappresentato dai lavori di un economista statunitense recentemente scomparso, Mancur Olson (si veda per tutti il suo libro: Ascesa e declino delle nazioni, Il Mulino, 1984). I gruppi di interesse organizzati (sindacati, associazioni professionali, organizzazioni di categoria, gruppi di pressione, consorzi industriali, ecc.) hanno una caratteristica comune: quella di fornire un servizio non escludibile, che avvantaggia tutti i membri del gruppo nello stesso tempo. Se un sindacato strappa un aumento salariale, ne ricavano un beneficio tutti i lavoratori del settore interessato. Se una lobby ottiene un provvedimento legislativo favorevole a una certa categoria, tutti i membri di quella categoria ne traggono un vantaggio. Ciò fa sì che la formazione dei gruppi di interesse sia ostacolata da un fenomeno noto agli economisti,
quello del free-riding, in virtù del quale individui razionali non finanziano volontariamente un bene di cui godranno comunque, se il contributo marginale di un singolo individuo non è significativo.
Il free-rider è come il cittadino che non paga le tasse, ma beneficia dei servizi pubblici finanziati da tutti gli altri. Naturalmente, se tutti si comportassero da free-rider, nessun servizio pubblico potrebbe essere offerto. E’ per questo che lo stato deve usare il proprio potere coercitivo per raccogliere le imposte. Anche i gruppi di interesse, se vogliono operare in modo efficace lungo un arco di tempo, devono ricorrere a un qualche meccanismo che superi il free-riding al loro interno. L’esperienza storica ci mostra come l’organizzazione dei gruppi con interessi comuni sia laboriosa e richieda molteplici espedienti (boicottaggi, legami ideologici, protezioni legislative, attività complementari, ecc.). Alcune categorie, inoltre, sono del tutto incapaci di auto-organizzarsi, a causa della loro numerosità e della mancanza dei necessari incentivi selettivi. E’ il caso dei disoccupati o dei contribuenti, dei consumatori o dei poveri, la cui voce giunge nell’arena politica più debolmente rispetto a quella di altri gruppi sociali.
I gruppi (o, per dirla con Olson, le coalizioni a fini distributivi) che riescono ad acquisire visibilità e peso politico possono utilizzarli per ottenere vantaggi specifici dai centri decisionali. Ciò crea una forte domanda di politiche distributive, con benefici concentrati e costi diffusi. Domanda che le forze politiche sono sempre più inclini ad accontentare per l’affievolirsi delle variabili ideologiche nella ricerca del consenso. E’ a questo punto che opera un secondo fenomeno di free-riding: le coalizioni a fini distributivi domandano benefici senza preoccuparsi dei vincoli finanziari, grazie alla diffusione o alla sommersione dei costi. In una società frammentata, un singolo gruppo non si rende conto che le dinamiche distributive creano un eccesso di trasferimenti e provvedimenti pubblici, o qualora se ne renda conto non ha nessun incentivo a rinunciare volontariamente al proprio beneficio, dato che rappresenta solo una piccola frazione della spesa complessiva. Ciò comporta problemi sia di equità (si creano flussi redistributivi a favore non dei bisognosi ma dei politicamente influenti), sia di efficienza (le risorse non raggiungono gli impieghi più produttivi e, per dirla con Olson, “l’incentivo a produrre si riduce, mentre aumenta l’incentivo a procurarsi una parte maggiore di ciò che viene prodotto”).
Di fronte a simili problemi, è possibile che nell’assetto politicoistituzionale si mettano in moto alcuni anticorpi: per esempio, in un sistema bipartitico, una forza politica potrebbe trovare vantaggioso abbandonare la tattica delle elargizioni settoriali, per abbracciare la tutela degli interessi diffusi. Anche la concertazione può essere usata per arrestare la spirale espansiva delle politiche distributive, chiamando le parti sociali ad assumersi le proprie responsabilità. Deve essere chiaro, tuttavia, che il metodo concertativo risolve soltanto il secondo tra i due free-riding esaminati: può arginare quello tra gruppi, ma non intacca quello olsoniano all’interno dei gruppi. In altre parole, persiste il problema che certe categorie sono sottorappresentate nell’arena politica. Di conseguenza, la concertazione appare più adatta ad affrontare problemi che investono da vicino le categorie con potere negoziale (come la politica dei redditi), piuttosto che materie di carattere generale (come la politica sociale). Solo nel primo caso, infatti, il metodo concertativo si rivela un processo decisionale che “internalizza” i costi delle diverse scelte. Il caso italiano conferma questa conclusione: la concertazione ha funzionato bene nella lotta all’inflazione, ma sta ostacolando una riforma del welfare state che tenga conto degli interessi delle generazioni future e degli esclusi dall’attuale sistema di protezione sociale.
Il miracolo olandese e il ristagno italiano
Anche un’analisi del genere, in ogni modo, tralascia alcuni aspetti. In situazioni particolari, è accaduto che le parti sociali abbiano adottato strategie orientate all’interesse generale. Per capire come questo sia possibile, deve essere presa in considerazione l’interazione strategica tra gli attori della concertazione. Un’ottima base per una riflessione di questo tipo è fornita dal saggio di Jelle Visser e Anton Hemerijck sull’esperienza dei Paesi Bassi (Il miracolo olandese, Edizioni Lavoro, 1998). L’Olanda degli anni ’80 e
’90 rappresenta un caso unico di riforme economiche e sociali. I successi di questo paese in termini di crescita e occupazione sono legati a una ricetta con tre ingredienti: moderazione salariale, riforma dello stato sociale, politiche attive del mercato del lavoro. A partire dall’accordo di Wassenaar del 1982, la politica dei redditi è stata gestita attraverso la concertazione, per aiutare le imprese nella competizione internazionale. Di fronte a forti segnali del mercato (in primis una disoccupazione alle stelle), le parti socialisindacati in testa- si sono rese protagoniste di una lungimirante assunzione di responsabilità. Ma nell’arena dei diritti sociali, dove i segnali del mercato sono intrinsecamente più deboli, la concertazione ha rischiato subito di diventare un fattore di immobilismo.
Solo una precisa volontà politica dei governi che si sono succeduti negli anni ’90 ha rotto lo stallo, superando i veti incrociati delle parti sociali.
Nell’arena del welfare, sono state le forze politiche ad adottare un’ottica generale e lungimirante, mentre gli interessi organizzati- sindacati in testa hanno adottato strategie di difesa corporativa, cercando uno scambio improprio con le scelte positive maturate in tema di politica dei redditi. Nel 1991, il governo Lubbers, sostenuto da una coalizione tra il Partito cristianodemocratico (Cda) e quello socialdemocratico (PvdA), avviò una revisione in senso restrittivo dei programmi sociali per invalidità e malattia, caratterizzati da abusi e usi impropri. Ne seguì la più grossa manifestazione sindacale del dopoguerra. Nelle elezioni del 1994, i socialdemocratici persero un quarto dei loro elettori (dopo avere perso un terzo degli iscritti), e i cristianodemocratici del primo ministro persero un terzo dell’elettorato. Nonostante la pesante lezione politica, la nuova coalizione di governo formata da socialdemocratici (PvdA), liberali (Vvd) e democratici (D66), guidata dal leader socialdemocratico Wim Kok, non abbandonò la strada delle riforme, continuando la revisione della sicurezza sociale e introducendo elementi di concorrenza organizzata (quasi-mercati) nella sanità. Dopo una prima fase di scontro frontale con gli interessi organizzati, il governo ha poi saputo riavviare la concertazione. Anche perché i successi di un policy mix composto da flessibilità e politiche attive del mercato del lavoro hanno dato i loro frutti, creando un nuovo consenso e fornendo una contropartita aisindacati. “Lavoro, lavoro e ancora lavoro”: è stato questo lo slogan del governo Kok.
La riforma dello stato sociale, come noto, non è un’impresa facile. Ma il miracolo olandese dimostra che anche un welfare state continentale di natura compensatoria, tutto incentrato sulla compensazione passiva del reddito, può essere riformato. I governi olandesi hanno avuto successo in una simile impresa, salvaguardando il ruolo della concertazione, perché hanno ripristinato il primato della politica al di là di ogni considerazione sul consenso di breve periodo. Quando si è rivelato necessario, hanno saputo mostrare la cosiddetta “ombra della gerarchia”: hanno fatto capire agli altri attori della concertazione che lo stato aveva una forte volontà politica
di riforma e sarebbe intervenuto comunque. Ciò è servito a contenere il conflitto distributivo e a limitare l’opportunismo dei diversi gruppi. Senza l’ombra della gerarchia, la riforma del welfare olandese sarebbe rimasta in ostaggio degli interessi organizzati, che per un lungo periodo hanno usato il loro status semipubblico e il sostegno dei loro aderenti come arma di interdizione nelle negoziazioni, per impedire la formazione di un nuovo consenso su politiche orientate all’interesse generale. Come concludono Visser ed Hemerijck, “una politica di concertazione funzionante può, paradossalmente, richiedere uno stato forte, capace, se necessario, di disapprovare”.
Per una sorta di eterogenesi dei fini, proprio i grandi sacerdoti della concertazione, come Cesare Salvi o Walter Veltroni, finiscono con il minare il funzionamento del metodo concertativo. Se le forze politiche dichiarano che la concertazione è diventata un fine e non un mezzo, e che nessuna decisione politica può essere presa senza un accordo preventivo con le parti sociali, allora il meccanismo si inceppa. Senza l’ombra della gerarchia, gli interessi organizzati non sono spinti ad adottare strategie orientate all’interesse generale, e il freeriding olsoniano dispiega tutti i suoi effetti negativi: i gruppi senza potere negoziale non sono tutelati e interventi capaci di aumentare il benessere sociale e la crescita economica sono ostacolati. La colpa, in ogni modo, non può essere imputata soltanto a qualche politico.
Sono la frammentazione politica e la debolezza istituzionale le vere radici del ristagno italiano. Senza un governo forte in grado di fare valere l’ombra della gerarchia, la concertazione- che ha dato ottimi risultati nella lotta all’inflazione- diventa un fattore di stallo se applicata ad altre materie, come le politiche sociali e del lavoro. Solo un cataclisma politico-elettorale o una
stagione di profonde riforme istituzionali potrebbero farci uscire dal vicolo cieco nel quale ci siamo infilati. Molto resta da fare prima che il ristagno italiano si trasformi in un nuovo miracolo sociale.