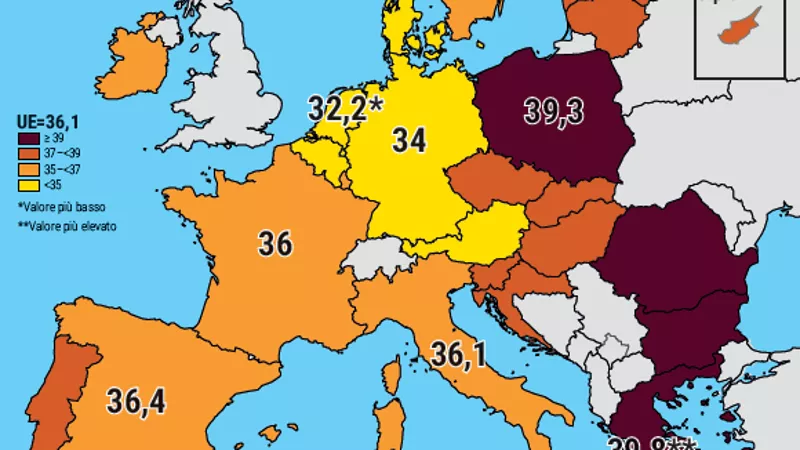Ridurre l’orario di lavoro a parità di stipendio aumenta la produttività e favorisce sia chi fa impresa sia chi lavora. È quanto sostiene una proposta di legge appena presentata da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra (Italia Viva, Azione e +Europa non l’hanno firmata). Curioso che aziende e sindacati non ci abbiano pensato da soli. Evidentemente, serviva il campo largo per spiegarglielo.
Ridurre le ore lavorative a parità di salario ricorda un po’ l’idea di Bertinotti di copiare la Francia sulle 35 ore, idea che portò alla caduta del governo Prodi nel 1998. Ma Pd, M5s e Avs si tengono lontani da questo approccio: non propongono di ridurre l’orario normale di lavoro fissato dalla legge italiana a 40 ore settimanali. Si limitano a introdurre, per tre anni in via sperimentale, una serie di sgravi contributivi per spingere i contratti collettivi a diminuire l’orario di lavoro senza tagliare gli stipendi.
Il tema è sacrosanto. Le nostre società devono riflettere su come proseguire la lunga marcia verso una riduzione equa del tempo di lavoro grazie al progresso tecnologico. E il tema è da sempre nel Dna dei progressisti, tanto che il primo maggio, la giornata dei lavoratori e delle lavoratrici, è legato alle lotte sindacali per la riduzione della giornata lavorativa nella seconda metà dell’Ottocento. Peccato, però, che gli strumenti introdotti dalla proposta demo-grillina siano in gran parte inutili e, nella parte residua, dannosi.
La proposta di legge stanzia 275 milioni di euro all’anno per finanziare un taglio del 30% dei contributi Inps versati dalle imprese, che sale al 50% per le piccole e medie aziende, nel caso usino contratti che riducono l’orario a parità di stipendio. Per dare un ordine di grandezza, se tutti i dipendenti fossero coperti da contratti di questo tipo, il costo sarebbe di 30 miliardi. I promotori degli sgravi sembrano i primi a credere che non funzioneranno. Anche i tre anni previsti sono pochi per incidere sui contratti nazionali, riguarderanno al massimo qualche contratto aziendale. E non è chiaro perché i contribuenti debbano pagare la riduzione dell’orario per pochi fortunati che lavorano in aziende già pronte a sperimentarla. Soldi insufficienti e mal spesi. Dopodiché, i promotori si devono essere accorti di questa sproporzione tra fini e mezzi. Ma la pezza è peggiore del buco.
La legge prevede un referendum (di dubbia costituzionalità) che consentirebbe a chi lavora di approvare una riduzione dell’orario da sottoporre all’azienda. Non se ne capisce l’utilità: se l’azienda non è d’accordo, a che serve un referendum? E se lo fosse, perché farlo? L’unico fine sembra delegittimare i sindacati, il cui ruolo è negoziare i contratti con la controparte. Inoltre, la legge prevede che, sulla base di questa sperimentazione, una commissione possa ridurre le 40 ore fissate dalla normativa vigente. Si arriverebbe così a estendere erga omnes, su tutti i settori, una riduzione sperimentata solo in poche aziende privilegiate. Non si comprende come una misura così svilente per il sindacato e la contrattazione collettiva possa provenire dalla sinistra. Sembra piuttosto il risultato della spinta alla disintermediazione dei 5 Stelle. Dal campo largo al campo giallo.
Come ha documentato Stefano Lepri su queste colonne, dopo decenni di stagnazione salariale, l’inflazione ha ulteriormente eroso le buste paga degli italiani, con un taglio reale del 4% dal 2020. In questa fase, se si vogliono introdurre sgravi contributivi, non avrebbe più senso destinarli ai contratti collettivi che aumentano i salari o alle aziende che creano nuova occupazione? Dopodiché, l’obiettivo di far sì che gli aumenti di produttività servano anche a ridurre le ore lavorate in maniera equa è giusto. Ma dobbiamo arrivarci senza misure calate dall’alto e con un ripensamento del nostro stato sociale. Oggi, l’inverno demografico e l’invecchiamento della popolazione ridisegnano il tempo delle famiglie. Mentre l’economia della conoscenza e degli algoritmi ridisegna il tempo del lavoro. Se la politica, di fronte a queste grandi trasformazioni, vuole riscrivere il contratto sociale che ci tiene insieme, non può che partire dal tempo. Da politiche che redistribuiscano il tempo dandolo a chi ne ha di meno. È questa la strategia di “investimento sociale” che sta diventando la nuova frontiera dei sistemi di welfare europei. L’idea è di mantenere una forte garanzia (passiva) del reddito, rendendola sostenibile (e poco usata) con un enorme sforzo di investimento in servizi di attivazione sociale, formazione, parità. Al nostro anchilosato stato sociale, per abbracciare la prospettiva dell’investimento sociale, servirebbero un bel po’ di misure: reddito di formazione, congedi paritari, servizi di sostegno alla non-autosufficienza, sussidi a chi lavora ma ha redditi bassi, formazione permanente di massa, comunità educanti, incentivi alla contrattazione collettiva, tempo di base. Tutte riforme che hanno in comune una caratteristica: liberare il tempo restituendolo alle persone. Lasciando che imprese e sindacati facciano il loro lavoro.
Vai al contenuto