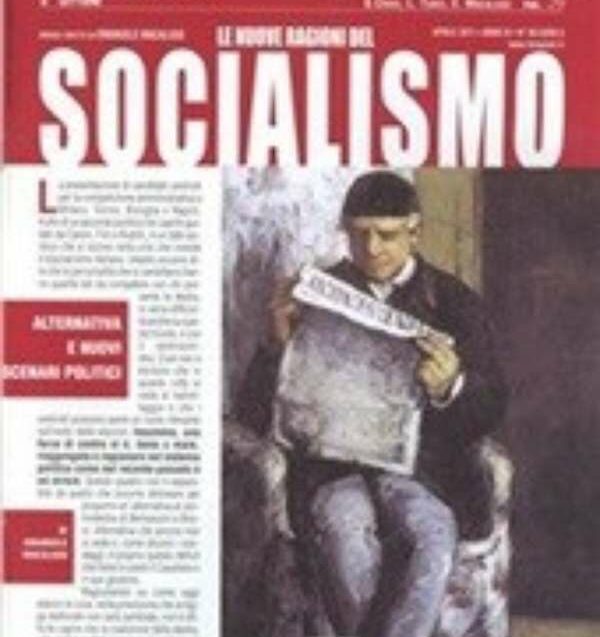Meno stato e più mercato, o viceversa? Intorno a questo dilemma si snodano da sempre le discussioni sul disegno ottimale delle politiche economiche e sociali. Come a voler seguire il pendolo ipotizzato da Albert Hirschman, per cui le pulsioni e le scelte di una collettività oscillano ciclicamente tra felicità pubbliche e private, l’enfasi sembra pronta a spostarsi nuovamente da privatizzazioni e concorrenza verso l’intervento pubblico. Le classi dirigenti italiane, in verità, sono solite vestire con una certa disinvoltura gattopardesca queste oscillazioni culturali. Negli anni ’90, è stata assorbita senza problemi una retorica vagamente liberista, salvo lasciare immutate rendite di posizione e barriere all’entrata nella maggior parte dei settori, dal credito ai servizi alla persona, dall’università alle professioni. Probabilmente, la nuova ondata interventista servirà a rafforzare interessi che già si sanno tutelari da soli, come il sottobosco pubblico-privato da sempre vicino ai decisori di politica economica, ma poco farà per l’individuazione di nuove ed efficaci politiche pubbliche.
Un’occasione per sparigliare un po’ le carte e mettere in discussione pigre coazioni a ripetere è offerta da un interessante libro di Alberto Alesina e Andrea Ichino: L’Italia fatta in casa. Indagine sulla vera ricchezza degli italiani (Mondadori). Sia detto subito: gli autori offrono una visione documentata, a prova di dati, dell’importanza della famiglia nella nostra economia, nonché una riflessione spassionata su vizi e virtù di questo modello. Senza prendere una posizione netta, tuttavia, sull’opportunità di mandare in soffitta (ammesso che sia possibile con semplici politiche pubbliche) il ruolo preponderante della famiglia italiana in tutti i gangli della vita sociale. La rilettura in chiave “politica” del loro libro offerta in quest’articolo è una forzatura di chi scrive.
Il primo elemento che emerge dall’analisi di Alesina e Ichino riguarda le dimensioni dell’Italia fatta in casa (rispetto a paesi “emblematici” come Stati Uniti, Spagna e Norvegia). Se considerassimo il tempo passato in casa per produrre beni e sevizi (cucina, pulizia, cura dei figli e degli anziani, giardinaggio, etc.), il prodotto interno lordo, che ovviamente esclude le transazioni non di mercato all’interno della famiglia, dovrebbe essere aggiustato al rialzo molto di più in Italia che negli altri paesi.
Tutto bene, quindi? La famiglia come risorsa nascosta (dalle statistiche) ma cruciale per il benessere italiano? Non proprio. I dati ci dicono altre cose interessanti. Rispetto agli altri paesi, sono soprattutto gli anziani (magari baby pensionati), le persone con maggiore capitale umano (laureate piuttosto che diplomate) e – soprattutto – le donne a produrre l’Italia fatta in casa. Se una donna lavora (e il tasso di partecipazione femminile è molto basso in Italia), lo fa in media per 7,1 ore al giorno contro le 8,8 ore dell’uomo. Ma sommando le ore spese a lavorare in casa con quelle sul mercato, le donne lavorano 80 minuti in più al giorno rispetto agli uomini: per la bellezza di circa 27 giorni all’anno! Il problema, per dirla con gli autori, è che “c’è qualcosa di potenzialmente patologico in un’Italia fatta in casa da persone con retribuzioni elevate, soprattutto da donne che dedicano alla famiglia il meglio di loro stesse”.
Anche se la lista delle possibili cause è lunga, è probabile che regole culturali e incentivi socio-economici congiurino tra loro per tenere le donne – anche quelle che mostrano grandi capacità nei loro percorsi di studio – lontano dal lavoro. Attenzione: non si tratta di mettere in discussione un modello sociale, forzando le donne a fare qualcosa che secondo qualcuno sono felici di non fare, per un’insana voglia di omologazione culturale verso i paesi anglosassoni o scandinavi. Si tratta, piuttosto, di lasciar decidere le donne, di ampliare le loro opportunità. Se, poi, preferiranno stare di più a casa rispetto agli uomini, niente di male. Si vedrà.
È con questo spirito che nasce la proposta di Alesina e Ichino: introdurre una tassazione differenziata tra uomini e donne. Ovvero: ridurre le imposte sul reddito da lavoro delle donne, finanziando l’intervento con una riduzione della spesa pubblica o con un (piccolo) aumento delle imposte sui redditi maschili. Si tratta di una proposta che risponderebbe a un duplice incentivo di efficienza economica (perché sarebbe tassato di meno il bene la cui offerta è più elastica, il lavoro femminile appunto) e di eguaglianza delle opportunità (operando una discriminazione positiva a favore di chi è svantaggiato da regole culturali e incentivi perversi posti da un sistema di welfare squilibrato). E anche i fattori culturali, per definizione difficili da modificare nel breve periodo, potrebbero adattarsi gradualmente ai nuovi incentivi.
Ma il familismo italiano produce altre distorsioni, sul piano economico e politico. La famiglia italiana offre una serie di servizi che in altri paesi sono offerti dai mercati finanziari o dallo stato sociale, partendo dall’assicurazione contro la disoccupazione per arrivare alla cura degli anziani. In Italia, si trova lavoro grazie alle conoscenze dei genitori: da qui la scarsa attenzione per le politiche attive del lavoro. L’istruzione conta meno dell’appartenenza ai circoli giusti: da qui la scarsa attenzione per la qualità del sistema educativo. Se la famiglia è l’erogatore principale di servizi, conviene restare a vivere nelle vicinanze: da qui la scarsa mobilità e l’impossibilità di selezionare. Se ogni realtà deve avere la sua sede universitaria, o un mercato del lavoro che copra tutte le qualifiche, è pressoché impossibile creare poli di eccellenza.
Dal lato politico – che è lasciato in ombra da Alesina e Ichino – la storia della Prima Repubblica offre un’altra faccia del familismo: stato povero, famiglie ricche. Gli alti livelli di debito pubblico accumulati attraverso politiche distributive (a benefici concentrati e costi diffusi) sono spiegabili anche dalla preferenza degli italiani per la cura del proprio orticello rispetto alla cosa pubblica. È proprio Edward Banfield, coniatore del termine “familismo amorale”, a spiegarcelo: il familista amorale pensa che il funzionamento del pubblico non lo riguardi e non si preoccupa di controllare i politici.
Da queste analisi, emerge una ricetta: meno famiglia, più stato (con politiche pubbliche di tipo nuovo) e più mercato (rimuovendo rendite e barriere all’entrata). Per premiare il merito, rimettendo in gioco le opportunità generazione dopo generazione. E per rianimare le energie del nostro paese dopo un ventennio di bassa crescita. L’alternativa – per chi può permettersela – è un “dolce declino”: fatto di crescita zero, ma anche di bella vita (vicino alla famiglia) grazie alle bellezze naturali del posto e alle ricchezze accumulate nel passato dalle proprie famiglie (non tutte, però).
Conosco l’obiezione: un programma di questo tipo non è politicamente fattibile. Se le barriere alla mobilità e i limiti del nostro stato sociale dipendono dal familismo, e a loro volta lo alimentano, c’è poca speranza di spezzare questo circolo vizioso. Il compito di una politica riformista, tuttavia, dovrebbe essere quello di costruire il consenso necessario. Magari sfruttando a proprio vantaggio il “senso della famiglia” degli italiani.
Ormai, sono tanti i genitori preoccupati per le scarse opportunità dei propri figli in un’economia stanca e disattenta al merito. O i nonni che non ne possono più di allungare la paghetta a nipoti che fanno fatica a trovare la propria strada. C’è un blocco sociale che ha molto da guadagnare nel lasciare il porto delle vecchie sicurezze per veleggiare in mare aperto, investendo su impegno e capacità. Aspetta soltanto una politica che gli faccia vedere che è davvero possibile.